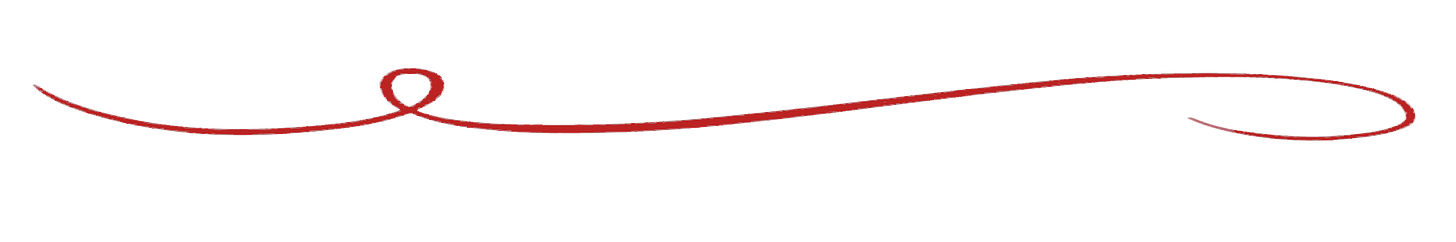🚀 Da zero a digital » Newsletter n° 130
Il tuo aggiornamento digitale: gratuito, indipendente, senza pubblicità. La tecnologia spiegata senza filtri, solo per te.
La sovranità digitale europea richiede investimenti miliardari per competere a livello globale, ma la vera forza sta nella via strategica dell’interdipendenza, che permette all’Europa di collaborare senza innescare costi insostenibili. Nel 2025, la sicurezza informatica resta un nodo cruciale: ancora oggi, password come “123456” dominano la scena, rendendo fondamentale proteggersi efficacemente. L’intelligenza artificiale in Italia vive una fase di evoluzione, con sfide importanti soprattutto nelle piccole e medie imprese, ma con un futuro tecnologico promettente. Intanto, l’euro digitale segna un passo avanti fondamentale, combinando sovranità monetaria e innovazione nei pagamenti digitali.
/sovranità digitale
Sovranità digitale europea: tra costi milionari e la via strategica dell’interdipendenza
In una fase storica in cui la sovranità digitale europea torna al centro delle agende politiche ed economiche, emerge con forza la domanda sul costo reale e sulla sostenibilità della piena autonomia tecnologica europea. Secondo Nicklas Lundblad, senior fellow del Center for European Policy Analysis (Cepa), l’Europa dovrebbe investire circa 3.600 miliardi di euro in dieci anni per affrancarsi dalla dipendenza tecnologica da aziende extraeuropee, in particolare statunitensi. Questa cifra corrisponde al 20% del PIL europeo e supera l’intera produzione economica annua della Francia, ponendo così una seria questione di equilibrio economico e strategico.
Il cuore del problema risiede nella concentrazione della dipendenza verso poche grandi aziende che controllano infrastrutture e servizi critici utilizzati quotidianamente nell’economia digitale: dai semiconduttori al cloud, dal software ai servizi digitali. Oggi l’Europa produce solo il 10% dei chip globali, e per colmare questo gap servirebbero investimenti enormi, pari a circa 680 miliardi di euro, solo per il settore dei semiconduttori, costruendo fabbriche allo stato dell’arte ispirate ai modelli globali più avanzati. La creazione di alternative europee per il software, che possa competere con giganti come Microsoft, Adobe o Google, richiederebbe almeno ulteriori 300 miliardi di euro in dieci anni, con la necessità di sviluppare ecosistemi sicuri, scalabili e accattivanti per sviluppatori e utenti.
Il capitolo più oneroso riguarda il cloud computing e l’intelligenza artificiale: replicare le capacità di AWS, Azure o Google Cloud e dei principali laboratori AI come DeepMind o OpenAI comporterebbe investimenti stimati in 500 miliardi di euro, accompagnati da altri 200 miliardi necessari a sviluppare piattaforme e servizi digitali come mappe, social media, motori di ricerca. Non meno importante è il settore del talento: attrarre e trattenere 500.000 professionisti di alto livello costerebbe all’Europa altri 250 miliardi. Inoltre, ogni anno di ritardo nell’innovazione tecnologica potrebbe comportare una perdita di circa l’1% del PIL, traducibile in un costo-opportunità di 1.700 miliardi in dieci anni.
Tuttavia, Lundblad evidenzia che puntare a un modello di totale autosufficienza tecnologica europea è economicamente insostenibile. La soluzione proposta è quella di costruire partnership strategiche resilienti basate su una interdipendenza intelligente con altri paesi e blocchi economici. In questa visione, l’Europa può diventare un hub di connessione e coordinamento collaborativo, avviando joint venture tecnologiche con paesi come India e Stati Uniti e promuovendo la diversificazione delle dipendenze tecnologiche. Tale modello ridurrebbe drasticamente i costi stimati, scendendo a circa 300 miliardi di euro in dieci anni, investiti in laboratori congiunti, organismi di standardizzazione e fondi di co-investimento.
Questa strategia non solo aumenta la sostenibilità economica, ma rappresenta anche un’opportunità geopolitica per affermare l’Europa come architetto di un nuovo equilibrio digitale globale, basato sulla fiducia, la cooperazione e la governance condivisa. Il vero banco di prova politico sarà la capacità dei leader europei di resistere alle lusinghe dell’autarchia e abbracciare una sovranità digitale fatta di interdipendenza e collaborazione, riconoscendo che questa costituisce un vantaggio competitivo unico, non replicabile con sole risorse finanziarie.
👉 Leggi l'approfondimento su CORRIERE COMUNICAZIONI
/sicurezza informatica
Le password più usate nel 2025: Perché 123456 continua a dominare e come proteggersi
Nel 2025, la sicurezza delle password continua a essere un punto critico per milioni di utenti in tutto il mondo. Uno studio condotto da Comparitech, basato sull’analisi di oltre 2 miliardi di password trapelate su forum e canali Telegram dedicati alle violazioni dei dati, conferma che la maggior parte delle persone sceglie ancora combinazioni semplici e facilmente prevedibili per proteggere i propri account. Le password più comuni, come “123456”, “admin” e “password”, dominano la classifica da anni, con la variante “123456” che appare nel database oltre 7,6 milioni di volte. Questo dato evidenzia una persistente fragilità nelle abitudini di sicurezza digitale, nonostante i continui avvertimenti degli esperti.
La top ten delle password più utilizzate è dominata da sequenze numeriche elementari, come “12345678”, “123456789”, “1234”, “Aa123456”, “12345”, “password”, “123” e “1234567890”. Queste combinazioni sono scelte per la loro semplicità e facilità di memorizzazione, ma rappresentano un serio rischio per la sicurezza degli account. Circa un quarto delle 1.000 password più comuni è composto esclusivamente da numeri, mentre quasi il 39% contiene la sequenza “123” e un altro 2% la sequenza inversa “321”. Tra le password minimaliste, spiccano esempi come “111111” e persino l’uso di caratteri come “****”, che sottolineano ulteriormente la tendenza a scegliere combinazioni semplici e facilmente prevedibili.
Un altro dato rilevante è che quasi il 4% delle password più popolari contiene parole chiave come “pass” o “password”, mentre altre includono termini comuni come “admin”, “qwerty” e “welcome”. A livello nazionale, emergono password come “India@123”, che sebbene meno stereotipate, risultano comunque vulnerabili agli attacchi. La lunghezza delle password è un ulteriore punto critico: il 65,8% delle combinazioni analizzate contiene meno di 12 caratteri, mentre solo il 3,2% supera i 16 caratteri. Password estremamente corte come “123” e “1234” continuano a essere tra le più usate, rendendo gli account estremamente vulnerabili ad attacchi brute force.
Gli esperti sottolineano come i moderni strumenti di hacking siano capaci di decifrare queste password deboli in pochi secondi. Riutilizzare password semplici e corte su più siti aumenta il rischio di compromissione massiva degli account. Per garantire una maggiore sicurezza, è consigliato l’uso di password lunghe almeno dodici caratteri, con una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. L’uso di password casuali, privi di schemi riconoscibili, è fondamentale, così come l’attivazione dell’autenticazione a due fattori per una protezione aggiuntiva contro gli attacchi anche in caso di password compromessa.
La ricerca si è basata sull’analisi di dati trapelati da forum e canali Telegram e ha incluso solo post confermati risalenti al 2025, con dati resi anonimi per garantire la privacy. La classifica si è costruita sul numero di occorrenze uniche di ogni password nel database ripulito, fornendo così una fotografia aggiornata e realistica dello stato della sicurezza delle password oggi.
👉 Leggi l'approfondimento su RED HOT CYBER
/intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale in Italia: uso reale, sfide nelle aziende e futuro tecnologico in evoluzione
L’uso dell’intelligenza artificiale in Italia presenta una realtà complessa e spesso fraintesa, segnata da un ritardo rispetto ad altri paesi sviluppati, soprattutto a causa di una diffusa carenza di competenze digitali. Nonostante l’opinione pubblica associ l’AI esclusivamente a modelli linguistici avanzati come ChatGPT e Gemini, la definizione legislativa italiana, recependo l’AI Act europeo, abbraccia una gamma più ampia di sistemi automatizzati che generano output influenzando ambienti fisici o virtuali. Questa visione più articolata include molte tecnologie AI spesso invisibili agli utenti che utilizzano software e piattaforme digitali.
Tra gli strumenti di AI più visibili e usati nei dati disponibili ci sono i chatbot generativi. Nonostante gli Stati Uniti dominino con oltre 2 miliardi di accessi a questi servizi, l’Italia si posiziona solo al 17° posto in termini assoluti, dietro a nazioni di dimensioni demografiche comparative più piccole come Messico e Filippine. Se però si tiene conto della popolazione, l’Italia registra circa 3,25 accessi per abitante, un valore che resta inferiore rispetto a paesi come Germania e Francia. Nel settore specifico di ChatGPT, che detiene più dell’80% del mercato della Generative AI, l’Italia si allinea a Germania e Francia, evidenziando una posizione intermedia.
Nel contesto produttivo, il quadro è ancora più critico: solo l’8% delle aziende italiane utilizza strumenti AI, ben distante dal 27,6% delle imprese danesi e al di sotto della media UE del 13,5%. Questo dato riflette la struttura economica italiana, dominata da piccole e medie imprese che spesso non dispongono delle risorse necessarie per investire in tecnologie complesse. Le imprese maggiori, invece, mostrano una significativa adozione dell’AI con almeno il 60% che ha implementato o sperimentato tali strumenti. Per un uso efficace dell’AI in campo produttivo è essenziale disporre di dati storici consistenti, necessari soprattutto per applicazioni come manutenzione predittiva e controllo qualità.
Si aggiunge inoltre il fenomeno della “Shadow AI”, l’uso non documentato di strumenti AI da parte dei singoli lavoratori, che introduce rischi di sicurezza e complicazioni giuridiche, soprattutto in un contesto normativo recente che impone obblighi di trasparenza e rispetto delle norme. Proprio la nuova legge italiana sull’AI, entrata in vigore a settembre 2025, estende l’AI Act europeo, introducendo anche sanzioni per abusi e regolando l’uso etico della tecnologia.
Infine, emerge un quadro critico sull’effettivo impatto dell’AI nel migliorare valore e qualità del lavoro. Studi recenti, come quello del MIT Media Lab, mostrano come la maggior parte delle aziende utilizzi l’AI soprattutto per aumentare la produttività individuale, generando contenuti come documenti e riassunti, ma senza rilevanti miglioramenti qualitativi. Questo fenomeno ha portato all’identificazione del fenomeno “workslop”, ovvero un aumento quantitativo del lavoro effettuato ma spesso a scapito della qualità. Il vero futuro dell’AI come motore di innovazione passerà quindi anche da un’evoluzione culturale oltre che tecnologica.
👉 Leggi l'approfondimento su GUERRE DI RETE
/protezione dei dati personali
Euro Digitale: sovranità europea e innovazione nei pagamenti digitali nell’era globale
L’euro digitale si afferma come una strategia chiave per rafforzare la sovranità monetaria europea e rispondere alle trasformazioni nel mondo dei pagamenti, dove il contante perde progressivamente terreno a favore delle transazioni digitali. Questo progetto, guidato dalla Banca Centrale Europea (BCE), non rappresenta una criptovaluta né una stablecoin, ma la versione digitale dell’euro fisico, emessa direttamente dalla banca centrale e destinata a essere utilizzata in contesti digitali con la stessa affidabilità e certezza giuridica del denaro tradizionale.
Con la crescente dipendenza da sistemi di pagamento gestiti da operatori privati, molti dei quali extraeuropei, come le grandi società statunitensi nel settore delle carte di pagamento, l’euro digitale punta a riconquistare il controllo sulle infrastrutture economiche fondamentali dell’Unione Europea e assicurare la resilienza dei sistemi finanziari europei. Allo stesso tempo, le Big Tech stanno sviluppando wallet e valute digitali proprie, aumentando il rischio di una perdita di centralità del denaro pubblico.
Il 2025 si configura come un anno cruciale nella fase di preparazione tecnica e regolatoria del progetto. La BCE ha già lanciato grandi tender per sviluppare i componenti tecnologici essenziali, come wallet digitali, sistemi di pagamento offline, infrastrutture di accettazione e soluzioni per la sicurezza e la prevenzione delle frodi. Parallelamente, il quadro normativo europeo sta prendendo forma con un voto previsto non prima del 2026. A seconda dei tempi legislativi e tecnici, i primi progetti pilota potrebbero partire già nel 2027, con una potenziale emissione reale dell’euro digitale entro il 2029.
Le transazioni con euro digitale promettono di essere anonime, immediate, sicure e prive di costi per gli utenti, offrendo al contempo strumenti flessibili come portafogli digitali (wallet) che potranno essere collegati o meno a conti correnti tradizionali, garantendo inclusività e sicurezza finanziaria diffusa. Questo sistema non vuole sostituire il contante, ma affiancarlo come strumento complementare più adatto alle esigenze del mondo digitale emergente.
Sotto il profilo geopolitico, l’euro digitale assume anche una valenza strategica nel contrastare la diffusione globale delle stablecoin e valute digitali estere, che potrebbero mettere a rischio la forza monetaria europea. La BCE, con membri come Piero Cipollone, sottolinea come l’introduzione della valuta digitale pubblica sia essenziale per mantenere la centralità e l’autonomia delle banche europee nel sistema economico globale, preservando l’uso della moneta pubblica contro la concorrenza delle valute digitali private.
In sintesi, l’euro digitale è una risposta articolata alla digitalizzazione e globalizzazione dei sistemi di pagamento, un banco di prova per la sovranità europea, la sicurezza economica e la tutela della privacy dei cittadini, che potrà trasformare radicalmente il modo di effettuare transazioni nell’Unione nei prossimi anni.
👉 Leggi l'approfondimento su AGENDA DIGITALE