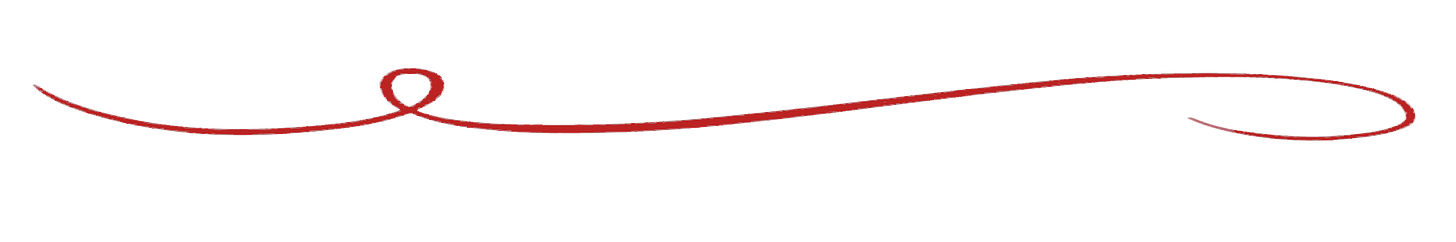🚀 Da zero a digital » Newsletter n° 121
Il tuo aggiornamento digitale: gratuito, indipendente, senza pubblicità. La tecnologia spiegata senza filtri, solo per te.
La UE ha fatto un passo importante equiparando il software ai prodotti fisici, estendendo la responsabilità per danni fino a 25 anni e garantendo così una maggiore protezione ai consumatori. Inoltre, nel mondo digitale moderno, gli smartphone sono diventati una vera e propria prigione invisibile, limitando la nostra presenza reale e rendendo urgente una rieducazione digitale per recuperare equilibrio e consapevolezza. A complicare il quadro, recenti casi come quello di ChatGPT, con conversazioni rese visibili su Google, hanno sollevato importanti questioni di privacy, sottolineando la necessità di interventi rapidi per tutelare gli utenti. Nel frattempo, il divario digitale si fa sempre più evidente: l’intelligenza artificiale, pur promettendo grandi progressi, rischia di accentuare le disuguaglianze sociali, lasciando indietro chi non ha accesso alle nuove tecnologie e creando nuove barriere di inclusione. L’era digitale, dunque, porta con sé sfide cruciali che richiedono attenzione e azioni coordinate.
La nostra newsletter dedicata al mondo digitale va in pausa estiva e riprenderà regolarmente ai primi di settembre. Questo breve stop ci permetterà di ricaricare le energie e preparare per voi contenuti ancora più aggiornati, ricchi di approfondimenti e novità sulle tecnologie che stanno plasmando il futuro. Vi ringraziamo per la fiducia e la partecipazione costante e vi auguriamo un mese di agosto sereno e ricco di ispirazione.
/software
La UE equipara il software ai prodotti fisici: responsabilità estesa fino a 25 anni per i danni causati
Di recente la Direttiva UE 2024/2853 ha stabilito un cambiamento radicale nell’ambito della responsabilità civile legata al software, equiparandolo ai prodotti fisici per danni causati. Questa normativa, che entrerà in vigore a dicembre 2026, impone ai produttori di software di rispondere dei danni materiali, di dati o fisici – inclusi quelli psicologici certificati – provocati dai loro prodotti. La responsabilità potrà estendersi fino a 10 anni dall’immissione del software sul mercato, con un massimo di 25 anni per danni alla persona che si manifestino tardivamente.
Una novità importante è il principio di responsabilità oggettiva, che alleggerisce l’onere della prova per i consumatori: sarà necessario dimostrare solo il difetto del software e il nesso causale con il danno, senza provare negligenza o colpa del produttore. La normativa si applica a un'ampia gamma di prodotti software, dai sistemi operativi alle app, fino alle intelligenze artificiali e ai software in cloud, includendo chi sviluppa, integra o commercializza software anche con software open source.
Quest'ultimo caso è particolarmente delicato: il codice open source resta esente da responsabilità solo se non monetizzato né usato per raccogliere dati personali, ma se viene incorporato in prodotti commerciali, la responsabilità ricade sull’azienda che lo utilizza. Questo potrebbe rappresentare un rischio significativo per piccole imprese e sviluppatori indipendenti, che potrebbero trovarsi esposti a contenziosi senza adeguate risorse per gestirli.
La direttiva prevede anche l’impossibilità di escludere la responsabilità tramite clausole di licenza, aumentando così la tutela del consumatore ma anche la pressione sulle aziende produttrici. Per prodotti importati l’obbligo ricadrà su importatori e rappresentanti autorizzati UE, portando uniformità normativa su tutte le produzioni digitali presenti nel mercato europeo.
Questa regolamentazione punta a rafforzare la sicurezza e la tutela dei consumatori nell’era digitale, ma pone scenari complessi per l’industria software, con rischi di rallentamento dell’innovazione e possibili spostamenti di mercato verso giurisdizioni meno restrittive. Le grandi aziende potrebbero adattarsi meglio grazie a risorse e assicurazioni, mentre le realtà più piccole potrebbero subire un impatto significativo, soprattutto nell’ambito dell’open source e delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale.
👉 Leggi l'approfondimento su ZEUS NEWS
/cultura digitale
Smartphone, una prigione invisibile che limita la presenza: la necessità di una rieducazione digitale
Spesso ci interroghiamo su quanto lo smartphone sia diventato un vero vincolo nella nostra quotidianità, trasformandosi in una prigione invisibile che limita la nostra capacità di essere presenti nel momento. Questa tecnologia, pur essendo uno strumento potente per comunicare e informarsi, ha creato una dipendenza che porta molte persone, soprattutto i più giovani, a vivere più nel mondo digitale che in quello reale. La continua attenzione alle notifiche, ai social media e ai contenuti digitali rischia di svuotare di significato l’interazione umana diretta e il contatto con l’ambiente circostante.
Lo smartphone genera una sorta di autosegregazione volontaria e involontaria, inducendo comportamenti in cui la ricerca di gratificazione immediata si sostituisce alla qualità della vita vissuta in presenza. I neurotrasmettitori coinvolti negli stimoli digitali provocano un cortocircuito tra soddisfazione momentanea e senso di vuoto interiore, creando una dipendenza subdola dalla tecnologia. Questo fenomeno ha, inoltre, impatti negativi sulla salute mentale e sulle relazioni sociali, isolandoci progressivamente.
Diventa quindi urgente rieducare alla presenza, promuovendo una consapevolezza che ci permetta di recuperare il contatto autentico con noi stessi e con gli altri. Spegnere per qualche istante il dispositivo, riscoprire la qualità del qui e ora, sono azioni necessarie per ristabilire un equilibrio tra mondo digitale e reale, tutelando così il benessere individuale e collettivo in un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla connettività costante.
👉 Leggi l'approfondimento su AGENDA DIGITALE
/intelligenza artificiale
ChatGPT, conversazioni rese visibili su Google: cosa è successo e come intervenire
L'articolo affronta un recente episodio che ha suscitato preoccupazione tra gli utenti di ChatGPT: alcune conversazioni private generate dalla piattaforma sono risultate visibili e indicizzate su Google, rendendole pubblicamente accessibili tramite normali ricerche sul web. Questo fenomeno ha messo in luce l’importanza cruciale della gestione della privacy e della sicurezza quando si interagisce con strumenti di intelligenza artificiale generativa.
Il problema è nato dal fatto che le chat, se non protette correttamente o se condivise in modo involontario, possono essere salvate o indicizzate da motori di ricerca. Ciò significa che informazioni che si ritenevano confidenziali diventano potenzialmente pubbliche, accessibili a chiunque effettui ricerche con termini specifici. Questo scenario solleva questioni fondamentali sulla protezione dei dati personali e sull’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate da fornitori come OpenAI.
Per gli utenti, la raccomandazione principale è di evitare di condividere dati sensibili o informazioni personali nelle conversazioni con ChatGPT, soprattutto se non si è certi delle impostazioni di privacy. Inoltre, è consigliato controllare regolarmente le impostazioni di sicurezza e utilizzare opzioni di anonimizzazione o cancellazione delle chat se disponibili.
Questa vicenda rappresenta un campanello d’allarme sulla gestione delle informazioni nei servizi basati su intelligenza artificiale, in rapida diffusione tra miliardi di utenti. Evidenzia la necessità di un approccio consapevole e informato verso le nuove tecnologie, che mettano al centro la tutela della privacy senza rinunciare all’innovazione.
👉 Leggi l'approfondimento su ITALIAN TECH
Divario digitale e intelligenza artificiale: come la tecnologia amplifica le disuguaglianze
Questo contenuto analizza in modo approfondito il crescente tema del divario digitale nell’era dell’intelligenza artificiale (IA) e come questa rivoluzione tecnologica stia, paradossalmente, accentuando le disuguaglianze sociali ed economiche a livello globale. Nonostante il grande potenziale dell’IA nel trasformare numerosi settori e migliorare la qualità della vita, la realtà dimostra che non tutti hanno uguale accesso a queste innovazioni, creando una nuova forma di esclusione tecnologica.
Il testo mette in evidenza come l’accesso incompleto o limitato alle infrastrutture digitali, alle competenze tecnologiche e alle risorse necessarie generi un divario che va oltre il semplice accesso a internet, coinvolgendo aspetti cruciali quali l’alfabetizzazione digitale, la formazione specifica sulle tecnologie emergenti e la disponibilità di strumenti avanzati. In particolare, le comunità meno sviluppate e i gruppi più vulnerabili rischiano di rimanere ai margini di un mercato digitale dominato da grandi aziende e nazioni tecnologicamente avanzate.
Wired sottolinea che per affrontare efficacemente questo problema è indispensabile un impegno coordinato di governi, industrie e istituzioni educative per promuovere una digitalizzazione inclusiva e garantire l’accesso equo a tecnologie intelligenti. È fondamentale sviluppare politiche mirate che incentivino la diffusione delle competenze digitali, investano in infrastrutture e favoriscano una cultura dell’innovazione accessibile a tutti, evitando così che l’IA diventi uno strumento che amplia le divisioni sociali piuttosto che colmarle.
L’articolo evidenzia, inoltre, come la lotta al divario digitale rappresenti una sfida non solo tecnica, ma anche etica e sociale, aprendo un dibattito imprescindibile sul ruolo e la responsabilità di chi progetta, distribuisce e governa le tecnologie del futuro.
👉 Leggi l'approfondimento su WIRED